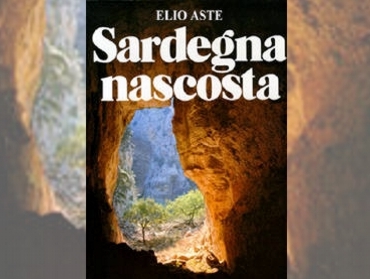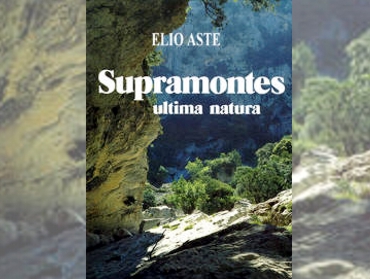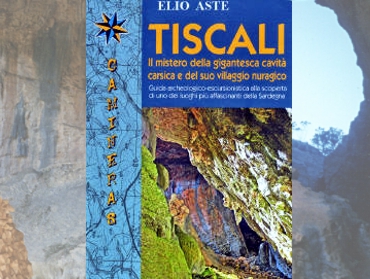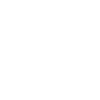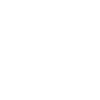Trekking
PER FORRE E FORESTE
ALLA SCOPERTA DI ANTICHI OVILI DIMENTICATI
(Durata del trekking: 2 giorni)
Da Oliena prendiamo la Strada Provinciale per Orgosolo. Poco dopo il tredicesimo chilometro (km.13,200), in prossimità del piccolo ponte sul rio Neòsula, abbandoniamo questa rotabile per divergere a sinistra su una sterrata, che inizia a svilupparsi in accentuata salita con tratti piuttosto sconnessi.
Attraversiamo una regione pedemontana, ricoperta da boschi di quercia, di leccio e da macchia mediterranea, dirigendoci verso le antistanti bastionate sud-occidentali del Monte Corràsi.
Il tracciato della carrareccia ora si snoda, sempre con forti pendenze, su una vasta zona, denominata Jànna ‘e Sùsu (Valico di Sopra), posta a circa 600 metri di quota, che risulta interessata da massicci rimboschimenti.
Con vari e stretti tornanti lo sterrato continua ad inerpicarsi, raggiungendo in breve la località Frùncu Tremùines (quota 740), in prossimità della quale lambisce il confine amministrativo col territorio del Comune di Orgosolo.
Da questo sito in poi il suo tracciato tende a dirigersi, sempre in accentuata salita, decisamente verso est, andando incontro alle vertiginose falesie del Supramonte di Oliena.
Stiamo risalendo ora una regione brulla, denudata dalla vegetazione, giacché attualmente attraversata da una gigantesca “fascia frangifuoco”. Nella sua prosecuzione la carraia tende ad essere fiancheggiata da una recinzione che racchiude un’estesa zona, interessata ad un intensiva piantumazione.
In prossimità di Punta Mancòsu (quota 848), a coloro che sono riusciti a giungere sin qui con un automezzo normale suggeriamo di parcheggiare in una piccola piazzola che risulta adiacente alla sterrata: soprattutto nei mesi invernali ed autunnali, infatti, le continue e forti pendenze, assieme al terreno scistoso e sdrucciolevole, potrebbero creare seri problemi meccanici e compromettere la sicurezza di guida; coloro, invece, che sono dotati di un’auto fuoristrada possono ancora proseguire per circa mezzo chilometro, sino ad incontrare una diramazione a sinistra, che occorre trascurare per avanzare d’una ventina di metri sino alla sommità d’un dosso, superato il quale è opportuno lasciare in parcheggio l’automezzo sotto un annoso leccio; da questo punto in poi occorre procedere a piedi.
La rupe di Punta Mancòsu (mt.848)
Dopo esserci affardellati gli zaini seguiamo in leggera discesa una mulattiera per un’altra ventina di metri, giungendo in prossimità di un’informe catasta di ruderi, appartenenti probabilmente ad una vecchia “dispensa” di carbonai o ad un antico ovile.
Da questo punto in poi la sterrata discende verso il basso con un tracciato pedemontano sempre più stretto e sconnesso, divenendo progressivamente poco più d’una traccia di sentiero.
Noi, viceversa, risaliamo una zona in accentuata pendenza, la quale ha inizio dall’informe mucchio di ruderi, alla ricerca della connessione del sentiero che dovrà condurci sulla sella di Scala ‘e Marras, la quale si sviluppa lungo un crinale della montagna. Vetusti lecci e macchia mediterranea ricoprono il suolo scosceso che stiamo attraversando, su cui è ormai assai difficile scorgere il tratto iniziale della traccia che dobbiamo percorrere, giacché la superficie del terreno risulta sconvolta dagli elementi naturali, ma soprattutto dal grufolare dei cinghiali e dei maiali inselvatichiti.
Risalendo a “zig-zag” intercettiamo finalmente il sentiero, che tende a svilupparsi a mezza costa, guadagnando progressivamente quota sui dirupati fianchi del Monte Corràsi, in gran parte ammantati da boschi misti, costituiti da lecci e da ginepri.
Stiamo introducendoci ormai nella selvaggia desolazione delle immense rocciaie calcaree e nei silenzi delle grandi selve della montagna, permeate da un’inesprimibile malia, che ispira emozioni e sensazioni che cercherò di trasmettere all’amico lettore.
Giganteschi monumenti naturali emergono dal verde della foresta
In prossimità del valico di Scala ‘e Marras si succedono in sequenza i remoti crinali dei monti di Barbagia
In alcune parti la traccia di sentiero scompare, quasi cancellata dall’abbandono e dagli elementi meteorologici; ma nei tratti critici alcuni “ometti” (1), collocati opportunamente dai pastori, ci aiutano a ritrovarla.
Seguendone lo sviluppo superiamo trasversalmente il fondo d’una ripida fiumara, attualmente in secca, che proviene dalla sommità d’un crinale del Monte Corràsi; quindi il tracciato valica il letto asciutto d’un altro torrente, ma dall’alveo meno accentuato.
Sella di Scala ‘e Marras. Sull’altro versante del valico l’ampia veduta dei Supramontes
Ovile Su Còrdu. Capanna principale ed ausiliaria (sotto), ormai abbandonate
In alcune parti la traccia di sentiero scompare, quasi cancellata dall’abbandono e dagli elementi meteorologici; ma nei tratti critici alcuni “ometti” (1), collocati opportunamente dai pastori, ci aiutano a ritrovarla.
Seguendone lo sviluppo superiamo trasversalmente il fondo d’una ripida fiumara, attualmente in secca, che proviene dalla sommità d’un crinale del Monte Corràsi; quindi il tracciato valica il letto asciutto d’un altro torrente, ma dall’alveo meno accentuato.
Una cisterna naturale, presso l’ovile, utilizzata dai pastori
Sempre in progressiva ed uniforme ascesa perveniamo in una zona ove la vegetazione d’alto fusto s’esaurisce. Comincia ad apparire una pietraia di quota: abbiamo raggiunto, infatti, circa 1.200 metri d’altitudine; in questo tratto il sentiero assume la denominazione di Scàla ‘e Màrras.
Attraversiamo per circa duecento metri una landa rocciosa, sassosa e desolata, sinché giungiamo sulla sommità di un valico, ove la salita s’esaurisce.
Ci troviamo ora in bilico su due “mondi” assai diversi: la veduta dintorno è assai estesa. Ad est il panorama s’apre quasi improvvisamente ed interamente sulla tormentata e selvaggia visione dei Supramonti, biancheggianti d’un calcare profondamente fessurato e stratificato, inciso più in basso da valloni misteriosi, coperti sovente da sconfinati manti di scure foreste.
La veduta si spinge sino alla glauca e lontana striscia del Tirreno, interrotta dalle ormai inconfondibili sagome del Monte Tulùi e del Monte Bàrdia, con alle pendici l’abitato di Dorgali: un quadro consueto ma sempre suggestivo, che dalle alte quote del Supramonte di Oliena in genere conclude la visuale verso levante.
Ad ovest, viceversa, la sottostante veduta, rischiarata dal sole, si schiude e si distende luminosa e rasserenante, con le immediate pendici ammantate da ampie e verdi superfici boscate, alle quali si susseguono, in armoniosa sequenza, i sovrapposti profili dei remoti crinali montuosi della Barbagia, avvolti da una tenue foschia.
Su questo stupendo panorama si distingue l’inconfondibile profilo del sacro Monte di Gonàre(2), così caro alle popolazioni delle regioni dell’interno dell’isola, mentre alcuni paesi, disseminati sul vasto orizzonte, risaltano come minuscole macchie grigiastre.
Da queste aspre solitudini cogliamo immagini e sensazioni, forti e dolci insieme, che riporremo nello scrigno dei nostri ricordi più cari: un simile cosmo, intatto e selvaggio (così a lungo immaginato e desiderato durante il nostro vivere quotidiano) si spalanca davanti a noi nella sua splendida concretezza e maestosità, ripagandoci abbondantemente delle nostre fatiche.
Riprendiamo il cammino. Sulla sommità del crinale il poco evidenziato tratturo si biforca. Proseguiamo sul ramo a sinistra sino a raggiungere una brulla radura di quota, ricoperta dalla gariga e delimitata da un lungo, basso e massiccio nodo roccioso, intaccato profondamente dagli elementi atmosferici, che il percorso per un buon tratto tende a lambire.
Quindi con direttrice sud-sud est la traccia di sentiero, superata la sommità del crinale in prossimità della quota 1.246, comincia a digradare lungo il versante orientale del Monte Corràsi, che in questi territori si presenta generalmente spoglio, nonché caratterizzato da imponenti fenomeni d’erosione e da un’intricata orografia.
Siamo giunti, infatti, in prossimità degli ovili di Brùnc’‘Arvu (Picco Bianco), che troviamo disabitati. Mentre procediamo ci appare, ad un tratto, la stretta e poco visibile imboccatura d’una voragine(3), quasi una mortale trappola, che s’apre a livello del suolo e che risulta opportunamente chiusa da grossi rami, posti trasversalmente dai pastori al fine di ridurne la potenziale pericolosità per gli uomini e gli animali. Questa cavità verticale, profonda poco più di venti metri, compare ad ovest dell’insediamento pastorale ed è impostata su una frattura diaclasica. Nel calarci nel pozzo carsico constatiamo che si tratta d’una stretta fessura, larga mediamente due metri e mezzo, che precipita su un fondo, occupato da un gigantesco conoide detritico, alto non meno di dieci metri.
A livello della sommità di questo assai abbondante accumulo di materiale di stacco e di provenienza esterna s’apre l’accesso d’un breve e stretto diverticolo con andamento pressoché orizzontale, che si sviluppa per una decina di metri con direzione sud-est, il cui asse planimetrico risulta ortogonale a quello del pozzo diaclasico che abbiamo appena disceso. Sul fondo della voragine sono stati rinvenute da chi scrive numerosi resti ossei di caprini e quelli d’un cane.
Come più sopra accennato a Brunc’‘Arvu, ad eccezione d’una capanna pressoché intatta (perché stagionalmente ancora in uso), tutte le altre strutture dell’insediamento pastorale, comprese le recinzioni per il bestiame, si presentano abbandonate e in rovina.
Nei pressi di questo sito, posto su una breve radura, parzialmente racchiusa e protetta da uno squallido ed angosciante anfiteatro roccioso, individuiamo un branco di mufloni. A circa duecento metri stanno ad osservarci, immobili lungo un nudo crinale calcareo. La loro diffidente vedetta è una vecchia femmina, che segue attentamente ogni nostra mossa.
Anch’essa sta immota su una roccia, in posizione dominante sul resto del branco: si limita soltanto a muovere alternativamente la testa quasi impercettibilmente, in modo buffo e caratteristico.
Tentiamo, infine, d’avvicinarci per poter fotografare questi artiodattili, ma allorquando superiamo la loro distanza di sicurezza scattano quasi simultaneamente in una frenetica fuga verso una sottostante forra, scomparendo in breve alla nostra vista fra le rocciaie e la macchia mediterranea.
Dagli ovili di Brunc’’Arvu (che risultano sparsi fra la quota 1.173 e la quota 1.146) ci dirigiamo verso nord al fine di localizzare un altro insediamento pastorale, situato più in basso e posto poco lontano, che tuttavia si trova in un luogo di difficile localizzazione, giacché è ubicato entro una sorta di labirinto di rocce: si tratta dell’antico ovile Su Còrdu(4), che consta di alcune capanne, che risultano introdotte nelle carte I.G.M. alle quote 980 e 1040.
A tal fine seguiamo un labile sentiero, che inserendosi entro uno spoglio compluvio carsico discende verso nord-est.
Ad un certo punto l’incerto tracciato scompare su una breve scarpata, cancellato da semoventi sfasciumi calcarei.
Da impercettibili segni, facendo appello a tutta la nostra esperienza, riusciamo tuttavia a ritrovare più in là la pista, ormai completamente abbandonata, la quale continua a svilupparsi in una sorta di “slalom” fra numerosi e sparsi gruppi di rocce, conducendoci infine in prossimità di una delle capanne dell’ovile. Su una radura sorge più staccata un’altra analoga struttura abitativa, posta a quota 980.
Gli abituri hanno cupole lignee che denunciano spiccata arcaicità; anche gli elementi che le compongono sono costituite totalmente da spezzoni di ginepro, ricavati da rami piuttosto contorti, che palesano la loro vetustà architettonica.
Le conseguenze d’un antico abbandono sono ovunque evidenti, particolarmente nelle stesse strutture dei rustici ricoveri, quasi completamente cadenti e privi delle porte di chiusura, sparse al suolo in frammenti ormai fatiscenti.
Sarebbe opportuno considerare, a tale proposito, che un essere umano, per poter condurre la propria esistenza in sì fatti luoghi, sprofondati nella più completa solitudine, dovrebbe essere dotato d’una cospicua capacità d’ambientamento e di grande rusticità, ma particolarmente d’un eccezionale spirito di sacrificio: tutte qualità che tendono ad attenuarsi presso le ultime generazioni degli ormai rari pastori, che operano nei Supramonti, i quali giustamente richiedono, per poter svolgere il loro duro lavoro, un minimo di comodità, ma soprattutto la possibilità d’accettabili collegamenti con mezzi meccanici ai vicini centri urbani. Ma in queste lande impervie e sperdute tali condizioni, per motivi logistici e topografici, non sono quasi mai soddisfabili.
Da quanto sopra accennato abbiamo avuto modo di constatare, conseguentemente, un progressivo ed inarrestabile spopolamento di queste regioni assai isolate, ormai frequentate quasi esclusivamente da bracconieri, ovvero da qualche individuo con la fedina penale non proprio immacolata, che talvolta vi soggiorna…per cause di forza maggiore; ma queste persone (sarebbe opportuno evidenziarlo e chiarirlo subito) non recano alcuna molestia o pregiudizio alla sicurezza dei trekkers o degli speleologi di passaggio, la cui presenza in questi territori è, del resto, attualmente assai rara, per non dire inesistente.
Tuttavia in sì fatte zone dei Supramonti (ma non solo in queste) occorre muoversi con sensibilità ed educazione, ma anche con discrezione e riservatezza.
Facciamo a ritroso (stavolta completamente in salita) il tratturo, al fine di rientrare agli ovili di Brùnc’’Arvu, ove sostiamo brevemente per rifiatarci e rifocillarci.
Alla quota 1.173, presso i resti d’una nudo basamento murario a pianta circolare, appartenente ad un’antica capanna dell’insediamento, inizia una traccia di sentiero che discendendo verso est attraversa un accentuato pendio, ricoperto di scaglie calcaree, sul quale vegeta miracolosamente un bosco misto, composto da lecci e ginepri.
Giungiamo su un breve altopiano. Fra varie incertezze, dovute alla precarietà del percorso, arriviamo finalmente all’ovile Su Fùmu (ovile Fumoso), situato a 947 metri di quota, la cui denominazione indica che il sito, ove sorgono i resti dell’insediamento pastorale, è spesso coperto di nebbia.
In prossimità d’un gruppo di rocce, che riparano le capanne dai venti dominanti, troviamo sparsi su una vasta area i resti delle strutture degli abituri e le loro pertinenze, abbandonate dall’uomo da chissà quanti anni. Tutto l’insieme si presenta alla vista in un quadro desolante e significativo.
Riprendiamo il cammino, che si mostra sempre più incerto, sinché finisce con l’estinguersi in prossimità della quota 958; ma dopo qualche decina di metri si evidenzia nuovamente, conducendoci presso un piccolo altopiano selvoso.
Il poco visibile sentiero discende ora su alcuni aspri costoni, rocciosi e fessurati, divenendo nuovamente di difficile individuazione.
Riusciamo tuttavia a seguirne il tracciato, facile da perdersi, che continua a digradare attraverso forti declivi, ammantati dalla foresta. Ad un certo punto la traccia, assumendo una direttrice orientata a nord-est, discende entro una coduletta, il cui sviluppo, segnato da profonde ed intricate erosioni carsiche, appare ingombro di brecciame, di massi e di tronchi ormai fatiscenti, abbattuti dalla folgore o dal tempo.
Qua e là si notano, tuttavia, anche fusti colonnari di piante nel loro pieno rigoglio vegetativo, mentre “moquettes” di muschio ammantano vaste zone nel fondo della vallicola, attenuandone l’aridità e la desolazione.
Sotto una folto bosco di elci l’effimero tracciato si congiunge alla quota 700 con un altro labile sentiero che ha origine dall’ovile Su Lidòne, rendendosi alfine più visibile.
Ci troviamo ormai nella zona terminale della boscosa e chiusa vallata carsica di Bàdde Su Lidòne (Valle del Corbezzolo), già a noi nota poiché attraversata con un nostro precedente trekking, proveniente dall’altopiano di Sòvana.
In lontananza spicca col suo chiarore l’inconfondibile sagoma calcarea di Punta Duas Vìddas.
Ci soffermiamo su un piccolo spiazzo, aperto nella foresta, nel quale si trova una piccola pozza melmosa, ove i cinghiali usano immergersi abitualmente per infangarsi e poter snidare in sì fatto modo i parassiti dalle loro setole.
Le loro numerose tracce si evidenziano con gli abbondanti accumuli delle loro deiezioni.
Nella breve spianata s’eleva uno spoglio nodo roccioso, inciso profondamente da tortuose e naturali fenditure.
C’inerpichiamo sulla sua sommità per meglio orientarci su quell’immensa distesa di vegetazione, che ci assedia.
Discendiamo per costoni incarsiti verso Bàdde Su Lidòne. Sullo sfondo l’inconfondibile vetta di Punta Dùas Vìddas
In quest’ora pomeridiana si presenta al nostro sguardo la visuale del costone montuoso di Serra Su Lidòne, che delimita e sovrasta ad oriente questa regione, così isolata e poco conosciuta. I margini della Serra, posti circa duecento metri più sopra del punto ove ci troviamo, si stagliano ad est con un andamento uniforme, interrotto verso settentrione solamente dall’emergente profilo dello spuntone calcareo di Punta Dùas Vìddas (quota 824).
Il sole radente della sera sta intanto abbassandosi sul versante opposto, dietro le incombenti ed ormai lontane chiostre montuose del Monte Corràsi, dalle quali siamo faticosamente discesi.
L’immensa ombra della montagna sta già calando repentinamente, finendo di coprire queste plaghe e lasciando illuminata solamente la cima del nudo picco roccioso di Punta Dùas Vìddas, che col suo candore calcareo, rilucente come un faro, si stacca inconfondibile sulle selvagge lande circostanti, ormai avvolte dall’imminente semioscurità crepuscolare e da una strana ed ovattata atmosfera.
Al fine d’uscire più celermente da questa vallata, cieca e senza sbocco, decidiamo d’attuare una variante al programma stabilito: anziché venirne fuori da sud decidiamo di risalire il lato est per guadagnare l’uscita dal vallone, col fine di superarne il bordo e sbucare quanto prima sull’altopiano carsico di Serra Su Lidòne.
Attendamento d’emergenza e fuoco di bivacco
C’inerpichiamo pertanto su un forte pendio scaglioso, immettendoci entro una linea di compluvio: una sorta di coduletta, orientata a sud est, ricoperta inizialmente da una folta lecceta, che ci conduce in prossimità della quota 852, posta sulla sommità d’un crinale.
La giornata volge al termine e gli zaini, che teniamo affardellati tutto il giorno sulle spalle, in un “raid” celere e quasi ininterrotto, cominciano a penalizzarci su quest’ingrata arrampicata.
Sbuchiamo finalmente sul ciglio dell’altopiano, uscendo nella zona mediana di Serra Su Lidòne, con l’intento di dirigerci speditamente alla volta degli ovili di Pala Grùssa, onde stabilirvi il bivacco di pernottamento.
Passiamo in prossimità della quota 852 (introdotta nella carta I.G.M.), percorrendo un breve altopiano, ammantato da fitti boschi misti, costituiti d’annosi alberi di leccio e di ginepro, che coprono un’immensa pietraia: un ambiente intatto e primordiale, conturbante nella sua apparente e sconfinata omogeneità.
Un tratto del desolato ed angosciante canalone senza nome, che converge alla Còdula di Pala Grùssa
Con l’aiuto della bussola, in un tenue alone crepuscolare, ci dirigiamo verso est, alla ricerca dell’ovile Pala Grùssa (q.579), che nella carta I.G.M. dovrebbe trovarsi, non lontano, su un digradante costone: Pala Grùssa in sardo significa, appunto, “Grosso Costone Montuoso”.
Ma le ombre della notte, ormai incombente, stanno per avvolgere ogni cosa. Perché quest’errare non divenga, oltre che vano, anche pregiudizievole alla nostra incolumità, decidiamo di fermarci sul bordo dell’altopiano.
Ci troviamo in prossimità della quota 800 (non introdotta nella carta) presso un annoso leccio, sotto il quale montiamo celermente la piccola e leggera tenda da trekking, destinata ai bivacchi d’emergenza. Qui ci accampiamo, predisponendoci ad una frugale cena. Sotto di noi discendono verso il basso forre scure e scoscese, ammantate da una fitta selva.
L’indomani mattina con la luce del giorno non ci viene difficile localizzare, non molto distante, il sospirato ovile ove avremmo dovuto trascorrere la notte, che tuttavia si rivela un vero e proprio ammasso di ruderi inabitabili, costituito dagli informi ruderi di due vicine capanne!
Attraversiamo luoghi che verosimilmente non hanno mai conosciuto orma umana
La visione di quest’altro insediamento pastorale in rovina ci fa riflettere sul fatto che in questo mondo supramontano, isolato e solitario, arido ed impietoso alberga una natura matrigna, che niente accorda all’uomo se non a prezzo di fatiche e di sacrifici inimmaginabili; ma che soprattutto tende a riappropriarsi di quel poco che concede: una verità cruda che i caprai-eremiti dei Supramontes ben conoscevano ed ancora, in parte, conoscono.
Dai resti del rustico ed antico rifugio, anche questo visibilmente abbandonato da chissà quanto tempo, facciamo a ritroso il cammino per circa ottocento metri, sino ad incrociare in prossimità della curva di livello, posta a quota 700, l’inizio d’una valletta in accentuata discesa e senza nome, che si configura come un ramo secondario, confluente ad un canyon, denominato Còdula de Pala Grùssa (Vallone del Grosso Costone Montuoso).
Ci accingiamo a discendere entro questa anonima coduletta con perplessità: avanti a noi si distende, infatti, una assai vasta, scoscesa e semovente superficie, ricoperta di massi, di pietre e di ghiaia. E’ una visione dantesca ed angosciante nella sua assoluta integrità ed arida desolazione, permeata tuttavia da un orrido fascino: un mondo cristallizzato da chissà quanti millenni, che si presenta come un poderoso fiume di grossi blocchi e di schegge calcaree, nel cui margine emergono miracolosamente, qua e là, alcuni lecci colonnari, in grado di resistere a quest’ostile assedio di pietre, seppur le figure contorte, spoglie e scheletriche di altre possenti piante, ancora erette ma ormai morte, attestano che non sempre la vita ha il sopravvento in un ambiente sì fatto.
Attraverso questa vasta e declinante pietraia, che tende costantemente a rendere precari i nostri passi, intercettimo alla quota 516 il canyon di Còdula de Pala Grùssa, ombreggiato dalla foresta, ove la pendenza si fa meno accentuata ed il terreno meno insicuro.
Man mano che avanziamo entro questo canalone osserviamo che l’ambiente tende a rinverdirsi ed a divenire meno ostile.
Ma anche qui una strana ed inesprimibile atmosfera, che vorremmo avere l’abilità di descrivere all’amico lettore, aleggia intorno: è forse il percettibile ed intenso umore della terra, che esplode con una forza misteriosa, materializzandosi nei possenti tronchi degli elci plurisecolari, talvolta prostati e contorti, seppur vivi, che si presentano coperti di muschio, simili a rugose ed attorcigliate figure, segnate indelebilmente dal tempo e da innumerevoli vicende meteorologiche.
Una natura integra, ostile, faticosa da attraversare, che s’impone ad ogni passo
Presso la confluenza del canyon di Pala Grussa con quello di Còdula S’Ozzàstru
Esplode questa forza vitale anche lassù, su quelle altissime pareti calcaree, che delimitano a tratti il canyon e che appaiono scolpite bizzarramente dal vento e dagli elementi, come pure su quelle inviolate cenge e su quei dirupi, che ospitano altri annosi alberi, quasi aggrappati sulle rocce e sporgenti sull’abisso.
Destreggiandoci fra massi e tronchi abbattuti, anche questi coperti di muschio, continuiamo il cammino verso est sino al termine del canalone, che si conclude in prossimità della quota 316, davanti ad uno strapiombo, corrispondente al punto di congiunzione con un'altra gola, denominata Còdula S’Ozzàstru, già percorsa e visitata con un nostro precedente trekking.
Avanti a noi si trova, ormai, un inagibile precipizio, alto circa 30 metri, che sembra precluderci ogni possibilità di prosecuzione con mezzi normali.
Ci accingiamo, pertanto, a calarci a “corda doppia”; ma una preliminare e breve ricognizione, a destra dello strapiombo, ci fa scoprire uno stretto e poco visibile passaggio, che ci consente di proseguire normalmente con i propri piedi sino al sottostante canyon.
Megalite prospiciente il punto di confluenza fra la còdula di Pala Grùssa e Còdula S’Ozzàstru
Di fronte al punto dal quale siamo discesi si trova un mastodontico lastrone di calcare, poggiato obliquamente sulla parete opposta della confluente còdula; verosimilmente si tratta di un antico segnacolo, che indicava in quel luogo l’esistenza dell’invisibile passaggio: una vera e propria via di fuga segreta per i profughi nuragici, i quali, sotto l’incalzare delle truppe legionarie, erano costretti a fuggire dai loro villaggi, posti nella valle di Lanaìttu.
Tale accesso risulta, infatti, pressoché invisibile per chi percorre il fondo del vallone.
Ho avuto modo d’osservare, comunque, qualche altro analogo segnacolo, in altri siti dei Supramontes.
Lungo il rimanente percorso non facciamo che ricalcare le orme d’un nostro precedente trekking, al fine di raggiungere la vallata di Lanaìttu, che per noi si configura come zona di partenza o di arrivo per gran parte delle nostre puntate nel Supramonte di Oliena: un ambiente di grandi spazi selvaggi, costituiti da rocciaie inviolate, da fitte foreste, da gole interminabili, da misteriosi mondi sotterranei, ove è ancora possibile riappropriarci della nostra capacità d’ambientamento, della nostra resistenza e della nostra dimensione umana, ma soprattutto della nostra intimità spirituale e dignità individuale, stimolate e messe costantemente alla prova da una natura splendida e grandiosa, che non accetta debolezze o mediazioni di sorta, ma che ti ripaga con la sua integrità, la sua purezza ed i suoi emozionanti ed indimenticabili spettacoli, da riporre per sempre nel profondo del nostro animo fra i ricordi più cari.
Una veduta della Còdula S’Ozzàstru
Autore Elio Aste