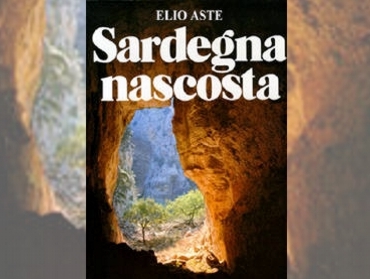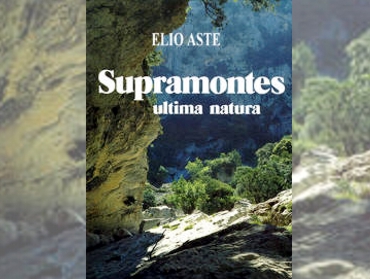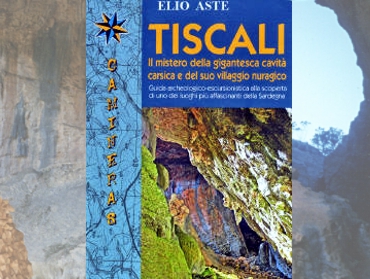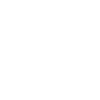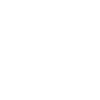PREMESSA
PREGHIERA DELLO SPELEOLOGO
RICORDO DI UN AMICO
PAGINA AUTOGRAFA DEL BIOSPELEOLOGO SERGIO PUDDU ALL'AUTORE
COME SI CREANO LE GROTTE E LE VORAGINI
Speleologia
PREGHIERA DELLO SPELEOLOGO
Torna al Menùe dovunque ho trovato palese il tuo segno.
Ma quaggiù più che mai la mia anima
è piena della tua pace.
Dammi, o Signore, la buona ventura,
ma se mi accadesse di perdere la vita che mi donasti,
fa che io riposi per sempre in questo incantato silenzio”.
MARCEL LUBENS

Speleologia
RICORDO D'UN AMICO
Torna al MenùRiempie il cuore di profonda tristezza ricordare un amico, prematuramente e tragicamente scomparso, il biospeleologo SERGIO PUDDU, fra i primi soci dello “Speleo Club di Cagliari”.
Fu un infaticabile scopritore di nuovi generi e di nuove specie della fauna cavernicola della Sardegna (artropodi), alcune delle quali sono state intitolate a suo nome dalla scienza (1)

Foto G. Pirodda
Nell’ambito di questo mio modesto lavoro sento pertanto il dovere di ricordarlo, dedicandogli questa parte del sito. La figura di Sergio mi torna soprattutto alla memoria per l’esemplare modestia e semplicità che lo contraddistinguevano, nonostante il suo notevole valore di studioso. Con le sue assidue e sistematiche indagini, le sue scoperte e pubblicazioni ha lasciato un’impronta incancellabile nel campo della biospeleologia sarda. I risultati da lui ottenuti, assieme ad altri ricercatori che con lui hanno collaborato, hanno inoltre convalidato il teorema, ormai quasi unanimemente riconosciuto dalla scienza, sull’immane evento, accaduto fra 30 e 20 milioni d’anni or sono, allorché un grande blocco della costa franco-iberica si staccò, dando origine alle attuali isole di Sardegna e di Corsica. Queste zolla di continente con un lentissimo movimento di traslazione e di rotazione si allontanò di ben trecento chilometri dalla posizione originaria, fermandosi infine al centro del bacino del Mediterraneo, ove attualmente si trova. Successive trazioni hanno separato la Sardegna dalla Corsica, originariamente unite. La biospeleologia ha definitivamente consolidato, con le scoperte di Sergio Puddu e di altri studiosi di entomologia, la fondatezza della teoria su quell’immane deriva. Alcune rare specie d’insetti troglobi di grande antichità, che lui scoprì, sono infatti strettamente affini, anche morfologicamente, a specie endemiche che vivono nei più profondi ed oscuri recessi delle grotte della Spagna e della Francia, ma non esistono nelle grotte della penisola italiana.Anche a questi eccezionali risultati di conoscenza scientifica, che coinvolgono la “tettonica a zolle” della geologia storica, l’entomologo Sergio Puddu ha dunque dato un suo decisivo contributo. Con questo affettuoso ricordo intendo, dunque, fare onore alla Sua memoria e contribuire al pieno riconoscimento del Suo valore di studioso.
Speleologia
COME SI CREANO LE GROTTE E LE VORAGINI
Torna al MenùL'acqua piovana durante la sua caduta ”cattura” nell'aria anidride carbonica, quindi si satura ulteriormente di questo composto naturale(2) attraversando l’ambiente compreso fra il margine superiore della vegetazione arborea od arbustiva e quello inferiore del detrito vegetale. Le superfici crepacciate delle montagne, particolarmente quelle di natura calcarea, assorbono facilmente l’acqua meteorica. Inserendosi nelle fratture delle rocce e nei giunti di strato questa produce nuove infiltrazioni ed allarga con la sua azione fisico-chimica le esistenti fessure degli strati freatici. L'azione fisica agisce con lo scorrimento, cui sovente s'unisce l'effetto abrasivo, giacché l'acqua trascina con sé sabbia e rocce frantumate di varia grandezza, che nel corso dei millenni sfregano, urtano e consumano le pareti, allargandole progressivamente. L'azione chimica è altrettanto rilevante, poiché l'acqua che giunge nel profondo delle rocce calcaree è ormai satura di anidride carbonica, che tende a trasformarsi in acido carbonico, in grado d'intaccare il calcare più compatto, compresa la dolomia. E' così, dunque, che dal triplice ed intimo connubio della roccia, dell'acqua e del tempo si sono create grandi e profonde cavità: le grotte e le voragini, che saranno argomento di questa sezione.
NOTA (2) Formato da un atomo di carbonio e due di ossigeno = CO2

Speleologia
LA GROTTA DI “BIDIGHINZOS”
UN SANTUARIO NATURALE, SEDE DI ATAVICI RITI
Torna al Menù
Assieme ad alcuni compagni d’escursione ci trovavamo sulla sommità del Monte Tìscali, presso le rovine dell’omonimo villaggio nuragico, da dove potevamo spaziare su un’assai vasta regione, dalla quale emergeva l’antistante Monte Guttùrgios (Monte degli Avvoltoi ), caratterizzato da alcuni precipiti costoni e dal solco vallivo della gola Sùrtana-Dolovèrre.
Il severo ambiente supramontano che circonda l’ovile di Bidighìnzos. Sullo sfondo il Monte Guttùrgios
Fra le varie falesie che in lontananza si distinguevano e che segnavano i fianchi della montagna una aveva particolarmente attratto la nostra attenzione, sia per la sua ampiezza, sia per la presenza di giganteschi nicchioni rocciosi che la foravano e che si presentavano semioccultati da una ricca vegetazione: tutto ciò incentivava la nostra curiosità ed il desiderio di visitarla, col fine soprattutto di scoprirvi eventuali nuove grotte. L’indomani, poco dopo l’alba, ci muoviamo a piedi dal nostro solito attendamento, posto nella valle di Lanaìttu percorrendo verso settentrione la ormai nota rotabile che costeggia le falde occidentali del Monte Tìscali. Incontriamo ben presto un bivio, il cui ramo a destra conduce al tratturo, a suo tempo da noi attraversato nel suo primo tratto per raggiungere l’imboccatura della Voragine di Tìscali (vedi precedente Itinerario N.5)
Stavolta proseguiamo invece lungo la carrabile, che dirigendosi verso nord-est costeggia il versante occidentale del Monte Tiscali sino a giungere ad un altro bivio, la cui impigliatura a destra ci porta allo sbocco del canalone di Dolovèrre, che s’apre fra l’immane sperone terminale del Monte Tìscali e le dirupate falde dei contrafforti del Monte Guttùrgios.
Rustici recinti destinati al ricovero dei caprini, costruiti ai piedi della falesia
Attraversiamo per un tratto una fiumara in secca, entro il cui alveo si sviluppa un antica mulattiera che discende dal vallone e che per un po’ risaliamo; quindi c’immettiamo a sinistra su un sentiero, che dalle pendici del Monte Guttùrgios s’inerpica verso est, là ove in lontananza avevamo scorto la gigantesca falesia.
Il tracciato risale snodandosi nella boscaglia; ad un tratto diviene più evidente, apparendo nel contempo ricoperto da deiezioni caprine, che ci fanno capire che poco lontano si trova un ovile. La pista infine attenua ed azzera la sua pendenza, penetrando una fascia di vegetazione arborea ed arbustiva.Sbuchiamo quasi improvvisamente su un vasto spiazzo, posto ai piedi di un’altissima ed estesa parete calcarea, forata da giganteschi nicchioni: la falesia che stavamo cercando è ormai avanti a noi in tutta la sua dirupata imponenza. Prospiciente il piazzale svetta un possente obelisco roccioso, che accresce la suggestione di questo luogo straordinario. Con grande meraviglia ci affacciamo così in un mondo inaspettato e quasi nascosto.
In primo piano una recinzione di rami. Sullo sfondo s’intravede l’obelisco
Scorcio dall’interno di un nicchione
Notiamo subito sulla spianata degli ampi recinti, destinati al ritiro dei caprini, delimitati alla base da grosse pietre che rincalzano le cortine di rami delle recinzioni. Gli steccati sono protetti dai soffitti aggettanti dei nicchioni, alle cui pareti risultano addossati. L’organizzazione di questa compagine pastorale è ben studiata e curata: su un lato, internamente al recinto più ampio, sono situati due piccoli ricoveri in ramaglie e frasche, destinati ad accogliere i capretti. Nello stesso spiazzo si trova un’altra recinzione più piccola, riservata verosimilmente a custodire i maschi delle bestie, giacché priva dei ripari per i nuovi nati. In questo primitivo ma funzionale insediamento tutto rispecchia una razionale gestione, frutto d’esperienza e competenza.
Ma un’altra sorpresa ci attende: costeggiando la falesia ci muoviamo nella direzione donde proviene un insistente abbaiare di cani. Superiamo un breve dosso, ingombro di megaliti. Proprio in corrispondenza alla parte terminale della falesia notiamo che sorge una capanna, posta nel fondo di un breve spiazzo e parzialmente inclusa entro un nicchione aggettante, che le incombe paurosamente. La struttura abitativa, a pianta rettangolare, ha muri di pietrame a secco. Il tetto risulta foderato da rami d’olivastro e di ginestra, usati abitualmente in Sardegna come efficiente e collaudata copertura straminea. Vi troviamo due caprai, coi quali c’intratteniamo per un po’ a conversare, riuscendo infine ad allontanare la loro iniziale diffidenza. Uno di essi, appreso che stavamo cercando nuove grotte, si offre di farci conoscere una cavità che lui afferma - è nota, solamente a pochissime persone (ci riferiamo all’anno 1972). Invitandoci a seguirlo si dirige verso un piccolo ambiente, attiguo alla capanna. Questo angusto vano, destinato al ricovero d’un somarello, è ricavato entro una cavità della roccia e risulta chiuso esternamente da un muro a secco sul quale si apre un’ampia porta d’accesso. In uno degli stipiti è addossato un antico bacile in pietra calcarea, pressoché ricoperto di muschio e sorretto da un basamento, anche questo in calcare, che nel complesso si presenta come una piccola e primitiva acquasantiera. Il manufatto è situato in corrispondenza ad un abbondante stillicidio, che cadendo dal bordo esterno del soffitto roccioso si raccoglie entro il catino lapideo: un modo semplice ed efficiente per disporre costantemente dell’acqua, elemento prezioso in queste regioni sitibonde, prive di una orografia di superficie, giacché questa scorre generalmente entro le viscere della terra.
L’acquasantiera raccoglie lo stillicidio di una parete rocciosa
Il piazzale sottostante la falesia
Il pastore c’invita a seguirlo introducendosi nella piccola stalla ipogeica; quindi sposta un paramento di rami, atto a mascherare la prosecuzione di un ambiente che continua ad ampliarsi entro la roccia, nel cui fondo si trova una breve scala a pioli, costituita da robusti rami di ginepro; l’estremità inferiore della scaletta è infissa in un basamento di pietrame a secco; l’altra estremità poggia sul bordo d’uno stretto e sbilenco pertugio semicircolare, che si apre superiormente sul calcare.Più in basso, ubicato di lato, si trova un largo orifizio, simile all’imboccatura d’un forno, che introduce ad una minuta cavità, assai bassa e disagevole, utilizzata dai pastori come un frigorifero naturale, giacché si presenta colma di bottiglie e da due damigiane. Quest’angusto e piccolo ambiente ipogeico probabilmente era stato, in antico, una “domus de janas”(1) ovvero un ripostiglio per offerte votive: vedremo in seguito come siamo giunti a tali ipotesi.
In alto l’angusto accesso alla grotta. In basso lo stretto pertugio del frigorifero
La nostra guida sale sulla rustica scaletta e s’inoltra nell’accesso superiore, sorreggendo la sua lampada. Ad uno ad uno lo seguiamo, infilandoci nella strettoia, da cui esce una fresca corrente d’aria. Sbuchiamo ben presto entro un vasto salone, in gran parte ricoperto dal nerofumo delle torce. A qualche metro di distanza dall’ accesso, attraverso il quale siamo penetrati, si trova sul suolo roccioso un piccolo e fondo incavo rettangolare, colmo d’acqua cristallina. A ben osservare, intorno al bordo calcareo di questa scaturigine, perennemente alimentata da una vena sotterranea, si notano antichi ed inequivocabili segni dell’intervento dell’uomo, che ha modellato alcuni particolari.
Stalattiti variamente colorate
Le rocce che la contornano sono, inoltre, levigate dallo sfregamento di generazioni di persone, che vi hanno attinto l’elemento necessario alla vita: l’acqua. Poco lontano, sul suolo saturo d’umidità, sono sparsi alcuni frammenti di terracotta, appartenenti a recipienti di diverso colore ed impasto, che testimoniano l’utilizzo di questa vena sin dai tempi più remoti.
Il pastore, sempre sollevando la lampada, prosegue il cammino. Ora la grotta si fa più ampia. In certi tratti neanche la potente torcia elettrica, orientata da un nostro compagno, è sufficiente ad illuminare compiutamente l’ ambiente ipogeico che s’estende nelle viscere della montagna. In fila indiana c’inoltriamo attraverso varchi, che spesso s’aprono fra straordinarie composizioni concrezionali, vere e proprie sculture surreali, che a volte paiono misteriose creature pietrificate, plasmate da una natura fantasiosa: un percorso che penetra un mondo oscuro, saturo d’un misterioso e tetro fascino. Il nostro procedere è costantemente accompagnato dalla presenza di colonne, di stalattiti e di stalagmiti dalle forme più strane ed inquietanti, talvolta gigantesche: veri e propri “totem” di roccia, che brillano d’umidore, così da sembrare creature vive. Sovente queste bizzarre formazioni si presentano variamente colorate per il loro contenuto di sali minerali di diversa composizione, solubilizzati e fissati per sempre nelle concrezioni durante il corso del loro lento sviluppo. Ci soffermiamo per un po’ in prossimità di un’imponente e policroma colata, che pare defluisca come una cascata pietrificata.
Colonne e stalagmiti, tinte da vari ossidi minerali in percolazione
Il residuo di un’antica torcia, abbandonata su un piano concrezionale ricoperto di nerofumo
Colata concrezionale multicolore, simile ad una cascata pietrificata
In questo luogo estremamente conservativo, che sa d’eternità, i miei compagni ed io ammiriamo, in raccolto silenzio, una profusione di forme e di colori inusitati, vivendo quest’esperienza con emozione e commozione.
Nel nostro intimo cerchiamo di capire il significato di queste orride bellezze (ammesso che i due termini siano conciliabili), che in un remoto passato hanno sicuramente colpito l’animo e la fantasia di altri uomini (più vulnerabili alle suggestioni di questa natura imprevedibile), i quali hanno saputo rispettare e tramandare ai posteri, pressoché integri, questi veri e propri monumenti naturali. La nostra guida ci conduce, “zigzagando” fra vari gruppi di colonne e di stalagmiti attraverso una stretta pista ipogeica, il cui sviluppo, in certi tratti, si distingue dal circostante manto concrezionale che ricopre il suolo, giacché risulta segnata dal nerofumo delle scorie carboniose che cadevano dalle fiaccole, sparse e calpestate successivamente da un protratto passaggio di antichi frequentatori. Questo mezzo d’illuminazione è sicuramente perdurato per diverse centinaia d’anni, sin quasi ai nostri tempi: lungo il percorso si notano, infatti, avanzi fatiscenti di torce, tuttora poggiate su alcuni ripiani calcarei, situati lungo il sentiero sotterraneo.
Gruppo di stalagmiti multicolori, veri e propri capolavori creati dalla natura
Una remota presenza umana è ovunque evidente. In certi punti si notano, oltre a tali residui, anche delle stalagmiti con segni di levigazione, giacché alcune di queste concrezioni erano state sovente utilizzate per sostenersi e poter così continuare a procedere.
Anche il nerofumo, presente in certe parti del soffitto roccioso, palesa un’intensa frequentazione umana di questa profonda cavità, che presenta tutte le caratteristiche, il mistero e la bellezza d’un tempio naturale(2).
Ciò, del resto, non deve stupirci. Infatti manifestazioni mistico-religiose entro le grotte furono verosimilmente praticate in Sardegna dal neolitico recente sino al protocalcolitico (3.500-2.700 a.C.), perdurando almeno sino al nuragico medio (1.600-1.300 a.C.) con sicuri attardamenti nelle regioni più interne dell’isola.
Inquietante raffigurazione, plasmata da una natura estrosa ed imprevedibile
Il culto principale dei protosardi era infatti di carattere idrologico, improntato cioè alla valenza sacro-lustrale dell’acqua, i cui rituali si svolgevano entro gli ambienti ipogeici naturali (caverne), ovvero in quelli artificiali dei “pozzi sacri” (3).
In entrambi i contesti l’antro rappresentava metaforicamente il ventre della divinità, entro il cui intimo l’uomo penetrava per adorarla e nel contempo attingervi l’elemento vivicatore e purificatore, essenziale alla vita: l’acqua, dono divino della Terra, la Gran Madre.
Ciclopica colonna che caratterizza uno dei vasti ambienti della bellissima grotta
Ma torniamo alla nostra grotta che, come abbiamo detto, ha tutta la valenza d’un sacro ipogeo. Superiamo un altro gruppo concrezionale “a canne d’organo”, le cui originali e fragili formazioni sono state religiosamente conservate, giungendo intatte sino a noi dal profondo del tempo. Un corridoio in accentuata salita, piuttosto disagevole, si stacca dalla galleria principale, “stoppando” ben presto su una parete rocciosa. Proseguiamo nel ramo principale. Man mano che c’inoltriamo la grotta diviene sempre più umida, mentre il suolo si presenta ricoperto da una patina concrezionale viscida ed infida. Perveniamo in prossimità di quella che a noi appare la parte terminale della cavità, la cui pavimentazione in questa zona è invasa da massi poco stabili e in via di disfacimento, arrotondati dalla costante azione fisico-chimica dello stillicidio e dall’umidità.
Sul fondo, che apparentemente conclude la grotta, fa spicco un nicchione, caratterizzato da una profonda fenditura, aperta verso il basso, che fa presumere una prosecuzione. Mentre ci accingiamo ad avvicinarci, per meglio esaminarla, il pastore che ci guida comincia a dare segni d’impazienza, informandoci che dovrà ormai tornare indietro per poter svolgere le proprie incombenze di lavoro. E’ giocoforza anche per noi rientrare. Seppur a malincuore iniziamo a fare a ritroso il percorso sotterraneo: ciò che abbiamo potuto osservare è stato, comunque, notevole e meritevole d’essere meglio indagato, tutelato e valorizzato.
Speleologia
LA GROTTA “CORBEDDU”
TESORI SCIENTIFICI E CULTURALI SEPOLTI NELLA TANA DI UN BANDITO
Torna al Menù
La grotta Corbèddu (1) è una cavità a sviluppo pressoché orizzontale, lunga circa centotrenta metri, ma ad onta della sua modesta estensione si contraddistingue per le sue specificità in campo paleontologico, archeologico ed antropologico.
Planimetria e sezione longitudinale della grotta
Per raggiungerla ci muoviamo dallo spiazzo, che s’apre antistante il modesto fabbricato, denominato “Rifugio”, vicino alla grotta Sa ‘Oche, nei cui pressi si distende un vasto e nudo crinale calcareo, profondamente segnato dall’azione fisico-chimica, dovuta allo scorrimento delle acque meteoriche superficiali.
Un "campo solcato" lungo l'itinerario per la grotta
Risaliamo questa china incarsita dirigendoci a vista verso sud-ovest, sinché giungiamo, dopo un quarto d’ora circa, in prossimità delle discendenti e tormentate pendici del costone S’Uscràdu. Su una paretina calcarea del Giurese si apre, fra la sparsa macchia mediterranea, l’ingresso della grotta. Questo accesso, per coloro che non conoscono il luogo, è tuttavia di difficile ubicazione.
Alcune anguste aperture secondarie, attualmente chiuse con muratura di pietrame e malta cementizia, si aprivano sul medesimo prospetto roccioso sul quale s’affaccia l’accesso principale, rivolto a nord-est, che si presenta come uno sbilenco pertugio, alto circa un metro e mezzo e largo al massimo circa un metro.
L'ingresso della grotta
Si discende attraverso dei massi, posti a mò di gradino, accedendo alla Prima Sala: un vasto ambiente asciutto, che risulta illuminato fiocamente dal vano d’entrata. E’ ormai accertato che questo ampio e comodo ambiente della grotta fu dai primordi frequentato abitualmente dall’uomo (seppur non continuativamente) sino all’epoca del bandito che le diede il nome. A tale proposito durante una mia precedente visita (1972), effettuata assieme ai miei abituali compagni d’escursione, avevo notato su alcuni blocchi calcarei della stessa sala il fondo di alcuni contenitori fittili, composti da un impasto grossolano. Queste parti residuali, ormai saldate alle rocce da patine concrezionali, dovute allo stillicidio, erano presumibilmente attribuibili ad un’articolazione del Neolitico(2).
Mastodontica colonna lungo il corridoio
La pavimentazione della grotta Corbèddu si presenta quasi ovunque formata da uno spesso strato di terra argillosa, mista a minuti detriti calcarei. L’ambiente della Prima Sala è fossile ma in tempi assai remoti doveva rappresentare lo sbocco a condotta forzata d’un torrente sotterraneo, che periodicamente l’allagava totalmente; infatti la volta e le pareti sono levigate e presentano in alcune zone le tipiche erosioni delle “marmitte inverse”, originate dall’acqua in pressione. Dalla Prima Sala si accede, tramite un corridoio, alla Seconda Sala. Da quest’ambiente si diparte un breve tratto di galleria, caratterizzata da un’imponente formazione colonnare, creatasi nel corso di migliaia d’anni in prossimità di una parete, situata a sinistra di chi s’inoltra. Dopo un accentuato restringimento si perviene alla Terza Sala, nella quale sono presenti interessanti formazioni stalagmitiche e colonnari. Quest’ambiente ipogeico è contrassegnato da uno slargo in leggera salita, originato da vari scollamenti del soffitto e delle pareti, avvenuti in epoche assai remote.
Simbolo di giustizia su una parete rocciosa, verosimilmente graffito dal bandito Corbèddu
Si prosegue sino ad un altro accentuato restringimento, oltre il quale si apre un angusto vano terminale, ornato da due colonnine, che appare piuttosto umido, poiché risulta interessato da un costante stillicidio. In questo ristretto ambiente, attraverso un breve piano inclinato, si giunge al modesto orifizio d’un pozzo, obliterato da depositi detritici ed argillosi, che in tempi remoti collegava la cavità al gigantesco sistema idrologico Su Bèntu - Sa ‘Oche - Su Gologòne. Qui si conclude lo sviluppo della grotta. Nell’aprile del 1974 decisi d’organizzare, un’altra perlustrazione, più meticolosa e prolungata rispetto a quella attuata nel 1972. Ebbi così modo di cogliere più adeguatamente diversi indizi, che mi fecero percepire in quegli inquietanti ed affascinanti ambienti ipogeici (allora poco conosciuti) un tangibile e remoto passato umano. Scrissi pertanto per un quotidiano sardo un ampio servizio(3), nel quale illustravo le peculiarità della grotta (almeno quelle al momento visibili), affermando infine profeticamente che entro la cavità in argomento sarebbero potute avvenire sensazionali scoperte.
Questa quasi avventata anticipazione dopo qualche anno incredibilmente si concretizzò! la grotta Corbèddu assunse il nome dal famigerato bandito barbaricino(4)a motivo del fatto che costui, vissuto verso la metà dell’ottocento, l’abitò a lungo, avendola eletta a suo covo prediletto.
Il bandito Giovanni Salis, noto Corbèddu
A tale proposito narra una leggenda che il brigante, assieme ai suoi accoliti, conducesse a forza entro il segreto dei suoi ambulacri quei nemici e delatori sui quali riusciva a mettere le mani. In una sala ipogeica, al lume delle torce, istituiva quindi un grottesco processo, che per gli infelici si concludeva generalmente con una condanna a morte. Resta il fatto che in occasione di quella mia prolungata visita avevo notato, graffita su una parete calcarea dell’antro, la raffigurazione stilizzata d’una bilancia, racchiusa da una spirale del diametro di circa ottanta centimetri, che tende ad avvalorare la leggenda e che in tale circostanza io ripresi fotograficamente, seppur vi sarebbe da considerare che la scritta “ Corbeddu Giovanni ”, incisa superior-mente alla spirale, è probabilmente apocrifa. Comunque è davvero singolare trovare questo simbolo di giustizia nel covo d’un bandito, una sorta di Robin Hood che, si narra, togliesse ai ricchi per dare ai poveri. Ma la fama della grotta non è tanto dovuta all’eco di queste fosche reminiscenze, ormai lontane nel tempo, quanto alle varie scoperte di notevole significato scientifico e culturale, avvenute in anni più recenti entro i suoi ambienti sotterranei. Certamente Giovanni Salis, noto Corbèddu non avrebbe mai immaginato che entro la “sua” grotta, sotto il suolo che abitualmente calpestava, potesse trovarsi un inestimabile tesoro scientifico e culturale, che avrebbe portato l’esistenza di quel covo alla ribalta internazionale, aprendo inediti ed ampi spiragli alla preistoria della Sardegna.
Ricostruzione delle fattezze del Prolagus sardus, un roditore ormai estinto, affine al coniglio
Ma descriviamo per ordine gli avvenimenti, che condussero successivamente alle straordinarie scoperte. Entro la cavità, già nell’ormai lontano 1967, il compianto Bruno Piredda, uno dei fondatori del “Gruppo Grotte Nuorese”, notò un’abbondante presenza di ossa di Prolagus sardus, un roditore della taglia d’un coniglio, estintosi ormai da diverse centinaia d’anni. Assieme ai resti osteologici di cervo elafo (l’esistente cervo sardo), di muflone e di altre specie dell’attuale fauna selvaggia isolana, egli osservò resti fossili di Prolagus sia in brecce ossifere che in consistenti cumuli di avanzo di pasto, risalenti al Neolitico. Questo roditore era affine al coniglio selvatico e alla lepre, seppur più diffuso: per i primi abitatori della Sardegna rappresentava, dunque, un’importante risorsa alimentare. L’anno successivo (1968), venutane a conoscenza, s’interessò della scoperta la paleontologa statunitense Mary Dawson del Cornegie Museum di Pittsburg (USA),la quale manifestò un grande interesse, prospettando infine una campagna di scavi per un’approfondita indagine scientifica, volta allo studio, al recupero ed alla ricomposizione scheletrica completa di detto lagomorfo.
Cranio e corna del paleocervo sardo Megaceros cazioti, estintosi ormai da migliaia d’anni
In seguito lo stesso Bruno Piredda collaborò validamente, assieme al suo gruppo, alle pertinenti ricerche sul campo. In tale circostanza, a seguito d’un laboriosa e certosina cernita, si giunse per la prima volta alla completa ricomposizione dello scheletro del Prolagus, che circa ventimilioni d’anni fà era diffuso in tutt’Europa; diciotto milioni d’anni più tardi, tuttavia, la sua area di sopravvivenza si era ormai ristretta alle sole isole di Sardegna e di Corsica. La stessa ricercatrice Mary Dawson, assieme ai colleghi olandesi Hans de Bruyn e Daniel Opplinger ricostruirono, sulla base dello scheletro, ormai completamente ricomposto, le fattezze di questo roditore, la cui totale estinzione sarebbe relativamente “recente”, giacché il grande paleontologo Forsyth Major (1898) riteneva che fosse sopravvissuto sino ai tempi storici.
Passaggio alla terza sala
Ma altre successive ricerche dovevano condurre, entro questa cavità, a scoperte strepitose, che avrebbero rivoluzionato la preistoria sarda. Accertato ormai che la grotta Corbèddu poteva essere una miniera d’informazioni di carattere paleontologico, furono intrapresi nel 1982 scavi sistematici nei vari ambienti ipogeici, indirizzati essenzialmente ad indagini, attinenti a questa materia. I lavori furono finanziati e condotti dall’Instituut voor Aardwetenschappen e Rijksuniversiteit di Utrecht con la collaborazione della Soprintendenza ai Beni Archeologici di Sassari e di Nuoro, rappresentate dall’archeologo nuorese Mario Sanges.
Formazioni stalattostalagmitiche
Le indagini conoscitive furono coordinate dal prof. P.Y. Sondaar per le diverse discipline (paleontologia, paleobotanica, antropologia,paletnologia, sedimentologia, paleoeconomia, archeologia). S’iniziò a scavare nella Seconda Sala. Le ricerche erano in un primo momento orientate ad approfondire particolarmente aspetti sulla fauna selvaggia della Sardegna durante il Pleistocene(5) e sull’ambiente nel quale viveva. Fra i vari reperti scheletrici rinvenuti si osservò, tuttavia, che quelli riguardanti il paleocervo sardo Megaceros cazioti (estintosi in epoche remote) non presentavano caratteri di nanismo, così come avviene nelle popolazioni di cervidi che vivono nelle isole. Anche la presenza dei resti scheletrici del canide sardo di taglia minuta, il Cynoterium sardous (aveva la dimensione di una piccola volpe), non spiegava l’avvenuta evoluzione verso una grossa mole del paleocervo sardo (Megaceros cazioti); inoltre l’esistenza del canide non si atteneva alla regola scientifica, che impone l’assenza di grossi carnivori nell’ambito delle faune insulari. Successivamente, a breve distanza di tempo, si rivelò, clamorosa ed emozionante (soprattutto per le sue conseguenti implicazioni scientifiche) la scoperta, avvenuta nello strato più profondo della trincea della Seconda Sala, ove furono messe in luce varie ossa di Megaceros cazioti, soprattutto mandibole, le quali presentavano singolari scalfitture, incisioni e lisciature, che assieme ad una particolare loro giacitura facevano congetturare un contestuale ed assai antico intervento umano sui resti recuperati.
In quei tempi remoti la mancata involuzione (come più innanzi accennato) di questo grosso mammifero verso forme di nanismo, tipica negli ambienti naturali insulari, poteva essere attribuita, quindi, alla presenza dell’uomo, predatore per eccellenza.
Avanzi d’un antico muro di sbarramento
Ciò convinse i ricercatori ad allargare ed approfondire, entro la grotta, i loro sondaggi ed a proseguire i lavori, estendendoli anche ad una ricerca antropologica ed archeologica. Conseguentemente gli scavi sistematici, portati avanti negli anni 1983 e 1986, furono particolarmente indirizzati alla raccolta di maggiori informazioni sull’eventuale presenza dell'uomo preistorico entro questa cavità.
Frammento d’arcata mascellare umana, rinvenuto negli strati profondi della grotta, attribuito ad un uomo vissuto durante il Paleolitico Superiore (13.590 anni fà, più o meno 140 anni dal presente). Illustrazione tratta da “PEOPLE AND CULTURE IN CHANGE” di Autori Vari – Edizioni B.A.R. – Centremead, Osney Mead – Oxford (England).
Sempre nella Seconda Sala fu quindi ampliata la trincea. Lo “strato1”, il più superficiale mise in evidenza una frequentazione umana, avvenuta nel Neolitico antico e medio, documentata da strumentari in ossidiana, generalmente accompagnati a resti scheletrici di animali domestici (capra, bue, maiale), ma anche di Prolagus, credibilmente avanzi di pasto.
Il sottostante “strato 2”, eseguito sino a 3 metri al di sotto del piano di calpestio, restituì resti di fauna pleistocenica (Prolagus sardus, Cynotherium sardous, Megaceros cazioti). Nello stesso strato infine fu messa in luce la scoperta più sensazionale, che confermava le speranze dei ricercatori: un osso temporale ed uno mascellare umani, entrambi giacenti nel medesimo livello ed appartenenti ad uno stesso individuo, che attestavano la presenza dell’uomo nel sito durante il Paleolitico superiore. La datazione radiometrica(6) ne attribuiva un’età di 13.590 anni, più o meno 140 anni dal presente. Ma la specificità di questi frammenti osteologici è soprattutto dovuta al fatto che ad oggi rappresentano i più antichi resti umani, rinvenuti in un contesto insulare, non solo per la Sardegna ma per tutte le altre isole del Mediterraneo.
Un’altra loro non comune particolarità è che queste ossa propongono caratteristiche morfologiche che non rientrano nella variabilità dell’Homo sapiens, ancor meno in quella dell’Homo sapiens sapiens europeo, palesando chiari segni d’un marcato endemismo, dovuto verosimilmente ad un assai prolungato isolamento geografico di una popolazione umana, comparsa nell’isola in associazione alla fauna endemica preneolitica. Tali morfologie antropologiche escludono, nondimeno, che i frammenti ossei possano essere attribuiti ad un uomo di Neanderthal o ad un occasionale “visitatore”, sbarcato dal continente. Da detto strato emersero, in associazione a pochi manufatti del Paleolitico Superiore, resti fossili appartenenti ad un numero ridotto di specie endemiche di fauna selvaggia, che mostrava anch’essa caratteristiche in linea con un’assai prolungata situazione d’insularità. Questi animali selvatici, soprattutto il cervide Megaceros cazioti, rappresentavano per l’uomo-cacciatore di allora (che come anzidetto assumeva le funzioni di predatore) il suo maggior sostentamento alimentare. Di particolare rilievo è inoltre il ritrovamento, avvenuto successivamente nel fondo della sezione di scavo della Prima Sala, di una porzione prossimale di un’ulna umana, assegnata ad un individuo diverso da quello a cui appartenevano le parti di cranio, rinvenute invece nell’attiguo ambiente ipogeico della Seconda Sala, di cui abbiamo accennato più sopra. Anche questa interessante frammento osseo presenta una morfologia differente da quella dell’Homo sapiens, essendo caratterizzato da un accentuato endemismo. Sempre nella Seconda Sala fu rinvenuto più recentemente un altro frammento osteologico umano, consistente nella porzione prossimale della prima falange di una mano, datato circa 20.000 anni dal presente.
Strumentari litici del Paleolitico Superiore sardo, datati fra 14.500 e 12.000 anni dal presente
Un ulteriore, significativo ritrovamento sulla presenza dell’uomo durante il Paleolitico Superiore ha consentito di retrodatarla a partire da 25.700 anni, più o meno 400 anni dal presente: in una trincea di saggio, aperta nella Prima Sala, situata presso l’ingresso, furono infatti rinvenuti frustoli di carbone assieme ad ossa di animali selvatici, strinate da fuochi (credibilmente di cottura o di bivacco), cui le misurazioni col radiocarbonio assegnavano quella remota età. Nello stesso ambiente una protratta attività umana, svoltasi sempre durante il Paleolitico Superiore, è attestata da scavi che hanno portato alla luce rozzi strumentari, alcuni in osso, ma per la maggior parte in selce, quarzo, calcare marnoso e ghoetite (raschiatoi, lame, bulini, ecc.) la cui datazione radiometrica li colloca entro un arco temporale compreso fra 14.600 e 12.500 anni dal presente. La loro specifica tipologia e lavorazione li distingue da coeve industrie continentali, (avvicinandole invece a quelle dell’isola di Corsica).
Ricognizione in un diverticolo
Per inciso tali manufatti sardi sono contemporanei a quelli dell’Epigravettiano(7) dell’Italia peninsulare, sia nella sua fase più matura che in quella finale (Balzi Rossi, Arene Candide, grotta Parmorari, grotta dell’Aquila, ecc.). La “facies” sarda, che si sviluppò in pieno Würm IV(8), si contraddistinse, quindi, per un marcato attardamento tecnico-culturale, che si protrasse sino alle soglie del Neolitico, anche questo presente nella grotta in tutte le sue articolazioni, compresa l’età “ media” (Cultura di Bonu Ighìnu), dischiusasi, maturata e conclusasi tra il 4.000 ed il 3.500 avanti Cristo), emersa anche questa dalle trincee di scavo, aperte nella grotta. Detta cultura risulta contraddistinta da tipologie fittili inconfondibili: recipienti costituiti da vasi globulari a collo più o meno accentuato, nonché da ciotole carenate ed aperte, decorate con impressioni a crudo, costituite da file di punti incisi "a pettine", da triangoli in alternanza ed erti, riempiti di fitte puntinature; ovvero ornati sugli orli o nel fondo con profonde tacche. Questo materiale è stato recuperato assieme ad avanzi di pasto, consistenti in gusci di molluschi marini e terrestri ed in resti scheletrici (talvolta strinati) di animali selvatici e domestici (prolago, cervo elafo, muflone, cinghiale, capra, maiale, bue, pecora). L'industria litica è quasi tutta in ossidiana (proveniente dal Monte Arci, presso Oristano) ed è costituita soprattutto da microliti geometrici a trapezio o a mezzaluna, nonché da punte di freccia con tagliente trasversale. Abbondanti gli strumentari in osso, (lesene, spille, punteruoli, aghi, alamari, ecc.). Particolarmente gli alamari risultano talvolta finemente lavorati con delle sottili ed artistiche incisioni. Anche gli oggetti d'ornamento sono ben rappresentati con elementi di collana e di bracciale, costituiti particolarmente da valve di Pecctunculus, Spondylus e Dentalium, forate all’umbone.
Imponente colonna nella Terza Sala
Dai dati di scavo è' emerso, dunque, che il rapporto col mare (costa orientale nel Golfo di Orosei) delle popolazioni appartenenti alla cultura di Bonu Ighìnu della valle di Lanaìttu fu caratterizzato da un'intensa frequentazione: negli strati relativi a questo contesto naturale furono rinvenute, infatti, conchiglie di varie specie, valve di patelle e di cozze, corazze di aragoste e di granchi, mandibole di pesci.
La grotta Corbèddu, covo di un temibile e famoso bandito, ha dunque offerto alla scienza alla cultura inediti ed assai interessanti elementi per una più ampia e chiara visione del remoto passato della Sardegna (9). Non è tuttavia da escludere che in altri strati profondi dei suoi sotterranei ambulacri siano ancora custodite altre sensazionali sorprese.